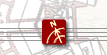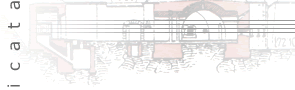| |
Dal 1835-1840 al
1866, nel nucleo urbano di Verona si attua il progressivo inserimento
di edifici e stabilimenti militari, destinati alle varie attività
ed esigenze logistiche dell’esercito absburgico. Ciò
è determinato dalla principale funzione strategica attribuita
alla città, secondo le disposizioni volute dal Feldmaresciallo
Radetzky. Dopo il 1848-1849 (prima guerra d’indipendenza nazionale),
a Verona è attribuito il compito di centro vitale del dispositivo
fortificatorio del Quadrilatero. Alle tre piazzeforti avanzate
di Peschiera, Mantova e Legnago competevano funzioni operative,
di combattimento, come piazzeforti di manovra (Manovrier Plätze),
destinate a sostenere l’armata nel teatro di guerra.
A Verona, oltre alla funzione di piazzaforte
di manovra, era attribuita la funzione di piazzaforte di deposito
(Depot Platz). Il suo assetto fortificatorio garantiva all’armata,
in ogni condizione, una base d’appoggio per ripiegamenti tattici,
ritorni offensivi, manovre di guerra. Inoltre, la posizione geografica
della città, in diretto collegamento stradale e ferroviario
con il centro della monarchia absburgica, e la sua posizione nel
teatro di guerra, protetta dalle altre piazzeforti avanzate del
Quadrilatero, conferivano a Verona le caratteristiche speciali
della piazzaforte di deposito.

Al suo interno, in tempo di pace, in speciali
edifici e stabilimenti militari, erano predisposti, conservati,
prodotti, amministrati, tutti gli equipaggiamenti, gli approvvigionamenti,
gli armamenti, le riserve, i materiali necessari all’armata
da mobilitare in caso di guerra.
Le risorse dell’armata, così concentrate
in un’unica città, non potevano essere esposte al rischio
di imprese nemiche. Secondo i principi dell’urbanistica militare,
alla piazza di deposito dell’armata doveva essere conferito
un grado di consistenza fortificatoria tale da non essere soggetta
a colpi di mano e da resistere, soprattutto, a operazioni di assedio
regolare, eseguite con artiglierie da fortezza. Inoltre, il nucleo
urbano nel quale erano insediati gli edifici e gli stabilimenti
militari doveva essere sottratto al bombardamento. La duplice linea
del campo trincerato di Verona garantiva le necessarie condizioni
di sicurezza, oltre alle funzioni di appoggio per le manovre dell’armata.
Verona, con le fortificazioni del primo e del secondo
campo trincerato (1848-1861/66), e il contemporaneo adeguamento
delle svariate attrezzature per i servizi logistici dell’armata,
divenne la principale piazza di deposito absburgica in Italia, da
ricordare tra le principali città militari d’Europa
nell’Ottocento.
Nel nucleo della città fortificata, o corpo
di piazza, ossia nello spazio all’interno della cinta magistrale,
la complessa pianificazione degli edifici e degli stabilimenti militari
rispondeva a due distinti ordini operativi. Il primo riguardava
i servizi logistici necessari alla piazzaforte; il secondo riguardava
i servizi logistici necessari all’armata d’Italia mobilitata
per la guerra.
Verona allora contava circa 70.000 abitanti.
Per la difesa della piazzaforte, del corpo di piazza e dei forti
esterni, nel 1866, in tempo di guerra, il presidio era costituito
da 13.000 soldati, ai quali si aggiungevano 1.600 cavalli, per le
varie esigenze di mobilità e trasporto; l’armamento
raggiungeva la dotazione complessiva di oltre 500 bocche da fuoco.
All’interno della città, per tutto
questo, erano state disposte caserme per acquartierare i soldati,
stabilimenti e magazzini per produrre e custodire le munizioni da
guerra e da bocca, nonché tutte le altre dotazioni necessarie
alla vita degli uomini, dei quadrupedi, e al combattimento.
Ulteriori pianificazioni riguardavano il secondo
ordine operativo appartenente alla piazza di deposito, ossia i servizi
logistici di supporto all’armata di campagna. Nel 1850, Radetzky
aveva stabilito che all’armata d’Italia, sul piede di
guerra, fosse conferita la forza di 70.000-80.000 uomini. Nel 1859
gli uomini sul campo di battaglia erano ben 110.000, con 384 pezzi
d’artiglieria e con diverse migliaia di quadrupedi; nel 1866
i soldati dell’armata in campo erano 75.000, con 168 pezzi
d’artiglieria.
A Verona, piazza di deposito dell’armata,
erano stati edificati i magazzini per predisporre, conservare e
custodire tutti gli equipaggiamenti, gli armamenti, le riserve,
i mezzi e i materiali da campagna appartenenti all’armata;
nonché gli stabilimenti per l’approvvigionamento degli
uomini e dei quadrupedi. Il servizio della Provianda, con le riserve
di grano e di fieno rinnovate periodicamente, era in grado di alimentare
l’intero esercito sul campo di battaglia, senza gravare la
collettività civile con requisizioni o depredazioni.
Fortificazioni ed edifici militari per i servizi
logistici fanno di Verona un caso ragguardevole. Qui sono attuati
in modo esemplare i principi dell’urbanistica militare ottocentesca,
che distingueva i fabbricati utili all’esercito in due classi,
ossia: gli edifici e gli stabilimenti militari necessari per le
esigenze esclusive della piazzaforte; gli altri edifici e stabilimenti
necessari per le esigenze generali dell’armata.
Solo le principali piazzeforti dello stato, alle
quali era assegnata la duplice funzione di piazza di manovra e di
piazza di deposito, erano dotate degli edifici di entrambe le classi.
È utile elencare, in dettaglio, gli elementi delle due classi,
singolarmente riscontrabili nella complessa pianificazione attuata
a Verona.
Edifici e stabilimenti militari necessari
per le esigenze esclusive della piazzaforte:
1. Caserme di fanteria e di cavalleria.
2. Stabilimenti della Provianda con i relativi
magazzini e depositi vari per i viveri; in particolare: - forni del pane con depositi per grano e farine;
- depositi di foraggi e paglia per i cavalli e gli animali da macello,
con i relativi ricoveri per questi ultimi;
- depositi di legna da ardere, per la guarnigione, per gli alloggi
degli impiegati e del personale;
- depositi per i letti e gli arredi da caserma.
3. Stabilimento delle monture, con
i relativi magazzini e depositi di vestiario per i soldati e finimenti
per i cavalli.
4. Edifici e altri stabilimenti per l’artiglieria
da fortezza; in particolare:
- polveriere per il tempo di pace e per il tempo di guerra; queste
ultime suddivise in principali e giornaliere;
- arsenale per la custodia delle armi portatili (armeria), delle
munizioni metalliche, degli equipaggiamenti, delle riserve e di
altre provviste e attrezzature per l’artiglieria;
- officine di manutenzione per l’artiglieria;
- laboratorio pirotecnico (per la preparazione delle cariche di
lancio) e del munizionamento;
Inoltre, in tempo di pace:
- deposito per l’artiglieria da fortezza;
- deposito per gli affusti, con i loro accessori e carreggi;
- depositi per legnami d’opera destinati ai paioli;
- alloggi per il Direttore dell’Arsenale e per il personale dell’artiglieria
tecnica, nell’arsenale.
5. Cantiere delle fortificazioni, nel quale
sono custoditi tutti i materiali e le attrezzature per i lavori del
Genio; relativi magazzini e depositi, con le officine e i locali per
la conservazione delle attrezzature antincendio.
6. Ospedale di guarnigione.
7. Comando di Piazzaforte e Residenza del Comandante, con il relativo
personale per il Comando di piazza, l’Auditorato (Giustizia militare),
il Cappellano, l’Intendenza (Commissario militare).
8. La Direzione del Genio, con gli uffici per gli ufficiali ingegneri
e il personale tecnico edile, e con l’alloggio del Direttore.
9. Prigione.
Edifici e stabilimenti militari necessari per le esigenze generali
dell’armata:
1. Stabilimento della Provianda con riguardo all’approvvigionamento
dell’armata in tempo di guerra.
2. Edifici e stabilimenti per l’artiglieria da campagna; in particolare:
- laboratorio pirotecnico, magazzino per le munizioni confezionate;
polveriere, officine; depositi per le riserve d’artiglieria
dell’armata, con le relative caserme e stallaggi.
3. Caserma dei pionieri, con i magazzini
e depositi per gli equipaggiamenti da ponte.
4. Magazzini e depositi per il parco d’artiglieria d’assedio,
con le relative attrezzature e materiali; inoltre caserme per le
truppe di artiglieria e del Genio addette alle operazioni d’assedio.
5. Grande ospedale d’armata.
6. Magazzino e deposito per le attrezzature da accompagnamento.
Infine, in casi speciali:
7. Grandi arsenali di produzione con fonderie e banchi di trapanatura.
La varietà degli edifici e degli stabilimenti
militari rispecchiava la complessa organizzazione logistica, posta
a fondamento dei grandi eserciti europei, dal secondo Settecento.
Il cospicuo insieme degli edifici è messo
in evidenza nella pianta topografica del 1865, nella quale, a colpo
d'occhio, gli edifici colorati in rosso fanno cogliere la consistenza
quantitativa e la disposizione della funzione militare urbana. Si
tratta di più di cinquanta edifici, o complessi di edifici,
singolarmente documentati nelle piante su carta millimetrata. In
essi non dobbiamo riconoscere esclusivamente un interesse di portata
urbanistica, nel documentare l’incidenza della funzione militare
nell’organismo urbano; ma un repertorio, assai raro, di uno
speciale genere di architettura, con tipi e forme a volte del tutto
speciali, e con opere di nuovo impianto, o ereditate dal passato.
Tuttavia, questi singolari edifici, generati dall’utilità
militare, concorrono a definire con le loro architetture la forma
della città civile ottocentesca.
Gli edifici ideati dagli operatori absburgici,
ufficiali formatisi alla Genie Akademie di Vienna, si inseriscono
come presenze di rilievo nel paesaggio urbano, si accordano ai luoghi,
commisurandosi alle preesistenze architettoniche, anche nel caso
di nuovi edifici disegnati nello stile dello storicismo romantico,
neoromanico (Rundbogenstil), o neogotico.
A Verona, gli edifici militari, connotati dal
carattere della civile rappresentanza, evocano ancora l’eterna
provvidenza absburgica.
:: top
::
CASERME
Dalla remota antichità, gli Stati provvisti
di un esercito permanente hanno provveduto alla costruzione di caserme
per il ricovero dei soldati in tempo di pace. I vantaggi di tale
provvedimento riguardano tanto l’utilità pratica, ossia
la disciplina, la sorveglianza e l’addestramento delle truppe;
quanto l’aspetto politico, ossia l’opportunità
di non gravare con l’onere di ospitare soldati la comunità
urbana e le residenze private. Tuttavia, ancora nel Sette-Ottocento,
in Europa permangono ordinamenti che attribuiscono alla comunità
civile l’onere diretto di acquartierare soldati nelle abitazioni
private; oppure, in alternativa, di costruire caserme, complete
di arredi e stallaggi, a spese della comunità urbana.
Già gli antichi romani avevano perfezionato
i modelli architettonici delle caserme, con impianti distributivi
lineari, a corridoio o con porticato a colonne, dai quali si accedeva
alle camerate comuni, disposte ognuna per quattro soldati (quaterni).
Durante il Medioevo non erano in uso eserciti
permanenti. Le truppe, per lo più arruolate all’occorrenza
(compagnie di ventura) erano ricoverate in attendamenti provvisori
fuori le mura delle città; o solo piccoli reparti erano acquartierati
nei castelli.
In epoca moderna sono da considerare determinanti
come modelli le caserme ideate da Vauban (1638-1715), al tempo di
Luigi XIV, con impianti a corpo lineare e a corte; esse razionalizzano
e migliorano, anche dal punto di vista sanitario, consuetudini costruttive
preesistenti. Nella storia dell’architettura militare europea
le diverse culture produssero autonomamente propri modelli costruttivi
e urbanistici: non trascurabili sono le caserme edificate nel Cinquecento
nelle città fortificate della Repubblica Veneta, particolarmente
a Peschiera, Palmanova, Verona.
Secondo l’ordinamento amministrativo e tecnico-militare
absburgico, la costruzione delle caserme nelle piazzeforti spettava
allo Stato, anche se in caso di necessità e di urgenza, permaneva
la consuetudine di utilizzare per l’esercito edifici di ragione
pubblica, comunale, o anche privati. Era questo il retaggio delle
antiche istituzioni militari.
Nell’Ottocento, comuni orientamenti di architettura
militare si riscontrano negli eserciti europei, frutto della circolazione
di idee edificatorie e tecnologiche, con crescente riguardo per
gli aspetti igienico-sanitari negli ambienti di vita collettiva.
Si perfezionano i tipi d’impianto a corpo lineare, con aggregazioni
d’insieme di più corpi di fabbrica su grandi corti aperte,
ben arieggiate e soleggiate, disposte per l’addestramento e
le varie attività di servizio.
Nell’architettura delle caserme si afferma
il carattere figurativo monumentale, della civile rappresentanza,
con soluzioni desunte dagli orientamenti stilistici propri del tempo
e di ogni singola nazione.
Nelle opere dei progettisti absburgici si riconosce
l’alto livello tecnico e artistico della progettazione, attenta
alla funzionalità, alla salubrità d’interno,
alla giusta economia nella costruzione. Ragguardevole è la
sobrietà delle facciate, nei diversi stili architettonici
- neoclassico, Rundbogen, neogotico - scelti in accordo
con i caratteri figurativi e ambientali dell’intorno urbano.
Oltre agli edifici absburgici di nuova costruzione,
a Verona un cospicuo insieme di caserme è identificabile
negli edifici religiosi demanializzati da Napoleone Bonaparte in
seguito ai provvedimenti di legge degli anni 1805-1806 e 1810, e
destinati all’uso militare. La conversione a caserme e altri
servizi per l’esercito francese, di ben tredici chiese e complessi
conventuali, permise di far fronte alla nuova dimensione urbanistica
della funzione militare, imposta alla città da un grande
esercito permanente. Dopo il 1814, i medesimi edifici vennero per
lo più mantenuti a servizio dell’esercito imperiale
absburgico, con successivi lavori di adeguamento funzionale, di
adattamento o di ampliamento.
Tra gli edifici militari della piazzaforte absburgica
vi è poi un insieme di speciale interesse storico, nel quale
si può riconoscere l’eredità di un lontano passato.
Sono gli edifici nati per l’uso militare che avevano conservato
per secoli la loro originaria funzione. Nell’Ottocento sono
ancora in uso, con l’avvertita necessità di adeguamento
strutturale, le caserme edificate dalla Repubblica Veneta, già
nel secondo Cinquecento, a presidio delle porte urbane, e la Caserma
Catena, del primo Seicento, ragguardevole esemplare del tipo
a corte.
Altre caserme, forse di impianto visconteo, o
quattrocentesco veneto, costituiscono un insieme di speciale persistenza
funzionale e di originale struttura architettonica. Si tratta della
sequenza lineare, e continua, di edifici situati lungo la muraglia
comunale-scaligera che guarda alla Cittadella. In aderenza al lato
di mezzogiorno, verso l’Adigetto, i fabbricati militari si
succedono dalla Torre della Paglia, presso l’Adige, fino alla
Gran Guardia.
Al cospicuo insieme delle antiche caserme, di
speciale interesse per la storia urbanistica e architettonica, si
aggiungono le caserme edificate ex-novo dall’Impero absburgico
con atti di studiato inserimento nell’organismo urbano, rispondenti
sia agli aspetti civili, sia alle esigenze militari. Le nuove caserme
veronesi sono dotate di struttura costruttiva ordinaria - non a
prova di bomba - come a Peschiera, poiché si giudicava
che il nucleo della piazzaforte, in caso di assedio, fosse al sicuro
da tiri di bombardamento d’artiglieria.

Tra le caserme absburgiche di Verona, due sono gli interventi
edificatori di maggior spicco per il loro significato tecnico e
artistico. Il grande complesso
del Campone, per fanteria e cavalleria, nel 1841 dà l’avvio
all’imponente ciclo degli edifici militari absburgici. È
un intervento esemplare, che ha il suo diretto antecedente architettonico
nelle caserme tardo settecentesche, in stile classico, di Theresienstadt,
la piazzaforte boema alla quale operò il feldmaresciallo
Carlo Pellegrini (1720-1796), veronese. Di singolare interesse è
poi la Caserma
di Castel San Pietro, per fanteria con distaccamento d’artiglieria,
edificata nel 1856 sui resti del castello visconteo. La sua architettura
introduce a Verona il nuovo stile storicistico mitteleuropeo: il
Rundbogenstil. Situata sul colle, la caserma istituiva un
punto di riferimento paesaggistico; nello stesso tempo, dalla sua
copertura merlata, a terrazza, si osservava l’intera città
fortificata.
Secondo la pianificazione logistica definita dopo
il 1850, per il dispositivo del Quadrilatero, le caserme
di Verona nel loro insieme erano in grado di acquartierare 9.000
uomini, con 1.600 cavalli, in tempo di pace; la capienza di presidio
poteva essere accresciuta a 10.000 uomini, in tempo di guerra.
:: top
::
POLVERIERE
Secondo criteri di sicurezza, nelle piazzeforti
absburgiche si distinguevano le polveriere per il tempo di guerra
(Kriegspulvermagazinen) dotate di struttura costruttiva con
volte a prova di bomba, dalle polveriere per il tempo di
pace (Friedenpulvermagazinen), dotate di struttura costruttiva
ordinaria, ossia con copertura non a prova di bomba. Queste
ultime si edificavano in aperta campagna, per preservare la città
da devastazioni in caso di esplosioni dovute a fulmini, incendi
o attentati. Nell’imminenza di un conflitto, le polveri in
esse contenute venivano trasferite all’interno della città
fortificata, nelle polveriere per il tempo di guerra. Queste erano
coperte con struttura voltata a prova di bomba, ossia atta
a resistere ai colpi delle artiglierie nemiche, in caso di assedio
o bombardamento.
L’impianto architettonico delle polveriere
veronesi esemplifica il tipo della polveriera ottocentesca absburgica,
derivato dai magazzini per le polveri ideati da Vauban nel Sei-Settecento.
Si tratta di edifici a pianta longitudinale, rettangolare,
con navata unica, o duplice, coperta da volta a botte con soprastante
massa coprente di terra, nel caso di struttura a prova di bomba,
ossia nelle polveriere per il tempo di guerra. Volte boeme (emisferiche),
senza massa coprente di terra, sono invece messe in opera nelle
polveriere per il tempo di pace, a struttura costruttiva ordinaria.
Le pareti laterali, all’interno, si articolano spesso in nicchie
archeggiate, i cui piedritti fungono da contrafforti per le spinte
orizzontali della volte di copertura.
Piccole finestre con sportelli metallici e varie
prese di ventilazione, con passante a tracciato spezzato, garantiscono
la necessaria illuminazione e la circolazione naturale dell’aria.
Si garantiva, così, la sicurezza contro l’intrusione
di corpi incendiari. La salubrità interna, prescritta per
la conservazione delle polveri, era perfezionata dal pavimento a
struttura lignea, distaccato dal terreno, con sottostante camera
ventilata comunicante con le prese di ventilazione perimetrali.
Le polveriere sono edifici del tutto originali, raramente
conservati. Sono esemplari architettonici di un genere costruttivo
speciale, da osservare, e tutelare, per il loro interesse intrinseco,
quali documenti storici della città fortificata absburgica.
|